Abbazia di Santa Maria di Staffarda
Vero gioiello disperso in mezzo alla pianura, circondata da campi di soya, mais e, solo da alcuni anni,
anche di riso, l’abbazia di Staffarda si profila, per chi percorre la S.S. 589 da Saluzzo in direzione di Cavour,
dominata dalla imponente mole del Monviso.


Classico borgo abbaziale, circondato da basse mura, con le case poste a ridosso della splendida chiesa, Staffarda
conserva ancora oggi i suoi caratteri originale e, malgrado le numerose distruzioni, non ultima quella che avvenne
durante la battaglia che vi si svolse nel 1690, regala tutt’oggi al visitatore splendidi momenti "full immersion"
in quello che fu il mondo monastico e contadino del medioevo piemontese.

Fianco nord Abbazia di Staffarda

Ingresso al borgo
Fondata dai monaci cistecensi su terre acquitrinose ad essi donate dal Marchese di Saluzzo, l’abbazia sorse su un
tempio preesistente tra l’XII e il XIII secolo. Grandi dissodatori di terre, votati alla preghiera ed al lavoro
nei campi, i monaci cistercensi, che seguivano la regola benedettina, bonificarono gli acquitrini che circondavano
la zona e diedero vita ad un insediamento che in breve divenne un caratteristico borgo, nel quale accanto al
complesso abbaziale (chiesa, convento, foresteria), trovavano posto le abitazioni dei villani preposti, di
supporto ai monaci, alla coltivazione delle terre ed alcune infrastrutture civili quali il bellissimo mercato
coperto in forme gotiche (del XIII sec.), che ancora oggi fa bella mostra di sé al centro del villaggio,
le cascine che facevano parte del borgo agricolo e che in alcuni casi recano ancora segni evidenti i segni della
loro antica funzione, come quella su cui, per quanto murata, è ancora leggibile l’apertura della porta di accesso
al borgo, sormontato da una grande croce e dalla torre di guardia. Il villaggio era dotato anche di mulini e
battitoi e di magazzini granari.


Mercato del XIII sec.
La decadenza del cenobio iniziò già con il XIV secolo e si accentuò dopo il XVII quando, a seguito
dell’acquisizione, da parte dei Savoia, del Marchesato di Saluzzo, esso venne affidato all’ordine monastico dei
Foglianti. Nello stesso secolo, come già sostenuto, nei dintorni della località si svolse una sanguinosa battaglia
che vide contrapposte, nel corso della Guerra della Lega d’Augusta, le truppe francesi agli ordini del famoso
generale Nicolas Catinat e quelle austro-piemontesi capeggiate dal Vittorio Amedeo II. Nel corso dello scontro,
che fu fatale al duca subalpino, l’abbazia subì una parziale distruzione ed in particolare ne risultò seriamente
danneggiato il chiostro, che ancora oggi risulta totalmente smantellato in due dei suoi quattro bracci. Parzialmente
restaurata dall’Abate commendatario Cardinale d’Estrées, la struttura si trovò nel primo `700 coinvolta in una
possente campagna di bonifica, durante la quale vennero prosciugate le risaie e gli acquitrini che ancora si
trovavano nei suoi dintorni, allo scopo di sconfiggere definitivamente la malaria e le altre malattie tipiche
degli ambienti palustri e malsani. Nel XIX secolo, infine, la commenda relativa all’abbazia di Staffarda venne
dapprima soppressa, quindi ripristinata ed affidata all’Ordine Mauriziano, cui la struttura appartiene tuttora.


Notevoli, nella chiesa e più in generale nel complesso abbaziale, innumerevoli motivi d’arte. Innanzi tutto la
cosiddetta Foresteria, ove i pellegrini generalmente in marcia verso le grandi abbazie d’oltralpe e verso S. Juan
de Compostella usavano sostare e consumare i pasti. Caratterizzata da enormi volte a vela, in puro stile gotico
la sala del refettorio evidenzia 4 enormi colonne in laterizio, sormontate da altrettanti capitelli istoriati
con motivi simili, ma diversi tra loro. Era questa una delle caratteristiche costruttive più tipiche degli edifici
religiosi eretti dai Cistercensi (anche per i capitelli delle colonnine che sorreggono le ogive del chiostro può
essere fatto lo stesso rilievo) e si rifaceva al principio che solo Dio è perfezione.


Foresteria.
Nella chiesa possono essere osservati uno splendido polittico (generalmente chiuso) di Pascale Oddone
(sec. XVI), un gruppo ligneo policromato con le statue della Madonna e S. Giovanni, poste ai lati del Crocefisso,
risalente anch’esso al primo `500 ed attribuibile ad uno scultore tedesco ed uno splendido pulpito ligneo con
scala elicoidale.
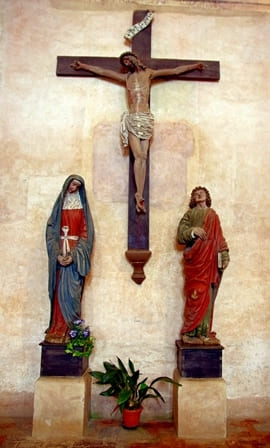
La struttura stessa della chiesa, con volte a vela e pilastri a pianta cruciforme
costituisce uno splendido colpo d’occhio; eccezionale l’austera sobrietà della struttura, totalmente priva di
affreschi (esclusa la più recente raffigurazione, nell’abside, del sole splendente), come voleva la regola
cistercense che impediva la riproduzione in immagine di Dio e dei santi.

Chiavi di volta
Notevoli, come già detto, anche il chiostro, parzialmente distrutto, la sala capitolare (in via di restauro),
il laboratorio in cui i monaci effettuavano i lavori di riparazione degli attrezzi ed una vicina sala in cui, il
curioso insediamento di una nutritissima colonia di pipistrelli, ha mobilitato i ricercatori della Regione Piemonte
e dell’Università di Torino che stanno conducendo studi sulle abitudini di questi animali.


Chiostro.
Accesso: Il borgo di Staffarda sorge isolato nella vasta pianura compresa tra Cavour e Saluzzo e
si raggiunge attraverso la direttrice Torino - Pinerolo - (A 55) e Pinerolo - Saluzzo (SS. 589 del Laghi di
Avigliana). Superato il grosso abitato di Cavour, circa 10 Km prima di Saluzzo, sulla destra, si incontra
l’abbazia (Km 50 da Torino).
©PIEMONTESACRO.IT. Tutti i diritti riservati.
Testo e foto di Gian Vittorio Avondo. Pubblicato il 24.01.2020

Ciao,
mi chiamo Stefano.
Piemonte Sacro è la mia passione dal 2001.
AIUTA il progetto Piemonte Sacro a crescere
DONA SOLO 2 euro! Te ne sarò GRATO .




